di Isabella Rauti
Non hanno quasi diritti, si sposano bambine, molte sono maltrattate, abusate, costrette a prostituirsi. Nascere donna a Kabul è sempre una sfida, a volte una tragedia.
Lo racconta una politica italiana che ha incontrato parlamentari e attiviste locali, che lottano per cambiare il Paese.
1° giorno
È’ la seconda volta che vengo in Afghanistan: l’anno scorso sono stata nella provincia occidentale di Herat, ai confini con l’Iran, ora, invece, mi trovo a Kabul, a Est, al confine con il Pakistan. Di Herat mi è rimasto il ricordo di un luogo misterioso che mi ha commosso, mentre a Kabul quello che sento, appena arrivata, è la paura. Sono ritornata qui per portare avanti progetti di cooperazione e di solidarietà rivolti ai bambini e alle donne. In questo Paese ci si sposa che si è ancora bambine e si fanno, in media, sei figli; la maggior parte non sa né leggere né scrivere, la vita scorre in fretta per le donne e sono poche quelle che arrivano a 50 anni di età. Kabul è un bunker: filo spinato, sacchi di sabbia, enormi muri di cemento (che chiamano T-wall), una lunga catena di check-point, guardie armate e, ovunque, la miseria. Mi guardo intorno: l’Afghanistan è una terra di sabbia, rabbia e sangue. E’ una valle schiacciata dalle montagne che è stata attraversata da decenni di invasioni straniere e di guerre civili e, dopo i sovietici, sono arrivati i talebani e tutto il loro odio per le donne. La guerra ha cancellato le tracce di questa civiltà millenaria, della Via della seta, dei giganteschi minareti, delle università. Dal 2001 le forze internazionali lavorano per la pace e gli italiani sono sempre stati in prima linea, a fianco della popolazione civile. Il sostegno proseguirà fino al 2014 quando il Paese passerà sotto il controllo del governo afghano. A quel punto, se vinceranno la pace e la stabilità, le operazioni militari si esauriranno e restaeranno gli impegni umanitari.
2° giorno
Esco dalla Green Zone, la zona militarizzata delle ambasciate: voglio attraversare il centro della città. Il traffico è caotico, le macchine sollevano nuvole di polvere che sembra arrivare fino al cielo grigio. Alzo lo sguardo e vedo le bellissime montagne dell’Hindu Kush e le baracche dei nuovi poveri di Kabul, quelli che vengono dai villaggi. a un semaforo un bambino stretto dalla mano di una donna completamente coperta dal burqua, ci chiede qualche soldo, appoggia la mano sulla maniglia dell’auto e prova per gioco ad aprire lo sportello. Seguo l’istinto e tento di aprire il finestrino: niente da fare. I mezzi con i quali mi sposto sono blindati, resta tutto ermeticamente chiuso, scatta il verde e ripartiamo: entrambi delusi. Ho ancora questa scena e il viso del bambino negli occhi, quando arrivo, con un indirizzo segreto, a Casa Shelter, la casa protetta per le donne maltrattate e abusate, coraggiosamente gestita da Selay Ghaffar, presidente della ong Hawca (Human Assistance for the women and the children of Afghanistan). Al momento, ci sono 45 ospiti, la più giovane ha 12 anni. Selay me le presenta una per una e mi racconta le loro storie: tutte uguali e tutte diverse. E’ la storia di Shafeya, la donna afghana che ho adottato a distanza con il progetto “Vite preziose”. Nella casa non c’è il riscaldamento, solo qualche stufa. Ci raduniamo nella stanza più grande, mi mostrano i loro lavori artigianali, borse di perline e vestiti, parliamo e intanto prendiamo il tè: per qualche istante sembra un normale pomeriggio tra amiche. Una di loro mi sorride: sul viso ha i segni del dolore della violenza e degli abusi che ha subito, ma nello sguardo c’è l’attaccamento alla vita e la forza di una dignità che sopravvive a tutto.
3° giorno
Oggi è stata una giornata dura. Sono stata all’ospedale Wazir Akhbar a trovare Sahar Ghul, la “sposa-bambina” segregata, seviziata e torturata per mesi dalla famiglia del marito perché rifiutava di prostituirsi. La sua storia ha commosso il mondo, ma Sahar non sa di essere diventata un simbolo internazionale della violazione dei diritti umani. E, forse, neanche le importa. Ha rischiato di morire, è sopravvissuta, ma i segni di quello che le hanno fatto ci sono, dentro e fuori. Appoggio sul letto i pacchetti che ho portato per lei (vestiti e vitamine), li scartiamo insieme. Sahar osserva perplessa una gonna, mi sa che qui proprio non c’ho preso… ma tutto il resto le piace. Infatti, a un certo punto, alza la testa e mi sorride teneramente. Finalmente vedo quello che è: una ragazzina di 13 anni. Le hanno impedito di essere una bambina, merita tutto l’aiuto del mondo perché da adesso cominci a vivere la sua età. Lascio l’ospedale con il cuore in gola. Salgo in auto e mi dirigo fuori Kabul, verso il carcere femminile e il Centro di riabilitazione per minori. Si tratta di due strutture nuove, costruite tra il 2006 ed il 2008. Mi presento con l’autorizzazione in mano, m il direttore non mi fa entrare, mi interroga come se in carcere io ci dovessi rimanere. Protesto, ma vedo che anche il mio interprete è in difficoltà… Non mi arrendo e, alla fine, riusciamo a passare. In carcere, ci sono 180 detenute e i loro figli al di sotto dei 7 anni (in tutto 55 bambini), e 20 agenti di guardia. Queste donne scontano, per lo più, reati che non rientrano nel codice penale, ma nelle leggi non scritte e più forti del diritto. Reati quali l’adulterio (pena da 1 a 6 anni di reclusione), l’abbandono del tetto coniugale, la prostituzione. Le famiglie le ripudiano, spesso non hanno un avvocato che le difenda e accade che passino dalla detenzione temporanea al carcere, senza un vero processo. Le condizioni igieniche sono pessime, non si respira, i bambini giocano tra loro senza giocattoli. Le donne sembrano molto spaventate, provo a fare qualche domanda (so per certo che non è vietato), ma le loro sono non risposte (e non è un problema di traduzione). Il Centro minorile – che di riabilitativo non offre niente – è anche peggio del carcere: 147 ragazzi, tra i 13 ed i 18 anni, detenuti per reati contro la sicurezza nazionale, furto e spaccio o per reati morali, come la pederastia (anche nei casi in cui ne sono stati solo vittime). Regalo dei cappellini e mi fanno una gran festa. Tanta gioia per così poco, sono n imbarazzo… Loro se ne accorgono e mi offrono in cambio una penna penna ricamata di perline luccicanti.
Ricomincio a respirare meglio quando raggiungo il giardino delle donne, chiuso dai talebani e rinato con la cooperazione italiana del ministero degli Affari esteri. Questo è un luogo di socializzazione femminile, un’oasi di civiltà dove, ogni anno, più di mille donne seguono corsi di formazione professionale, studiano informatica, inglese, letteratura, elettronica, fanno scuola guida e prendono la patente!
L’Afghanistan che vuole cambiare si costruisce qui e così. Ma anche nel reparto maternità dell’ospedale Esteqlal, esempio per innovazione e organizzazione, e nel Centro ustioni dove vengono ricoverate le “autoimmolate”: donne giovanissime che si danno fuoco per disperazione. Quelle che arrivano qui spesso si salvano, ma restano sfigurate, il che significa portare un marchio di condanna a vita.
4° giorno
Oggi incontro Sima Samar, presidente della Commissione afghana per i diritti umani. arrivo da lei intimidita: le donne come lei sono la garanzia degli sforzi sociali del Paese per la democrazia e la libertà. Ascolto le sue parole e penso “indietro non si torna”. Respiro la stessa determinazione la sera, a cena a casa della parlamentare Fawzia Koofi. le donne elette sono il 25% del Parlamento (più che in Italia) ed il 18% del Governo: le parlamentari presenti mi dicono che non sono certo disposte a fare un passo avanti e tre indietro. Né a scendere a compromessi sulla pelle delle donne. Niente burqua per loro (solo il capo coperto: per scelta), e gli occhi aperti sull’Afghanistan di domani.
Grazia – Oltre il velo il mio diario afghano
[File pdf - 1 Mb]




 FIRMA LA PETIZIONE
FIRMA LA PETIZIONE





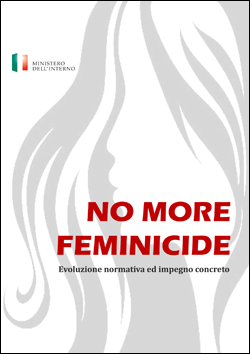

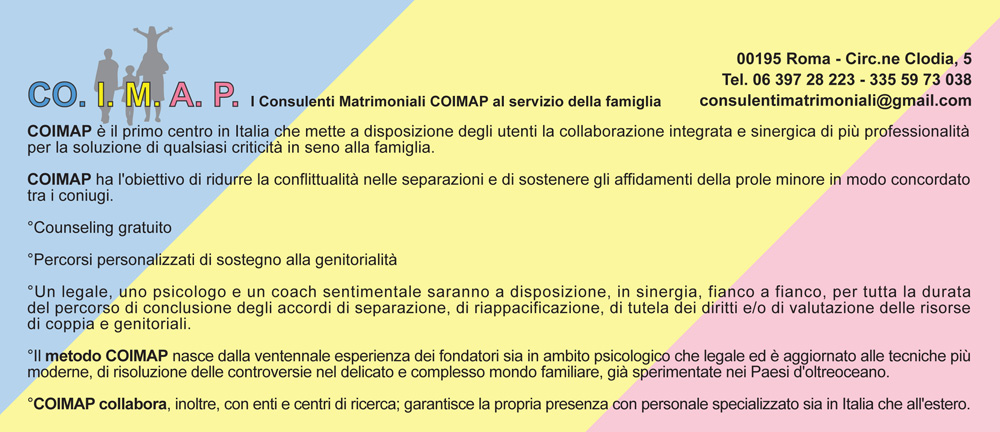
Stay Connected