di Isabella Rauti
Tre giorni a Herat. Ospite dei militari italiani. La moglie del sindaco Alemanno ha voluto vedere da vicino la realtà afghana. E ha scritto un diario per noi
Herat (Afghanistan) dicembre
Lo sguardo dei bambini, il lavoro dei militari, la fatica delle donne. Isabella Rauti, consigliera regionale del Lazio e membro dell’ufficio di presidenza del Consiglio, è andata in Afghanistan per toccare con mano, la vita quotidiana di un popolo in cerca di pace. Ecco il suo diario, in esclusiva per Oggi
Domenica 14 novembre
Oggi parto, per l’Afghanistan, il regime talebano è stato rovesciato nove anni fa, ma ogni giorno si “lotta per ricostruire la normalità che ì terroristi, i signori delta guerra e i commerciane dì oppio continuano a minacciare. L’Italia è in prima fila, impegnata nella missione internazionale di pace Nato/Isaf, nella Provincia di Herat. Sì lavora per creare le condizioni di governarne locale e di stabilità necessarie per realizzare il processo dì Transizione che dal 2011 al 2014 porterà per gradi il Paese sotto il totale controllo afghano. Nell’ambito del Prt, il Provincial reconstruction team italiano, operano il Ministero degli Esteri e la Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo. Militari e civili collaborano per aiutare la popolazione costruendo infrastrutture, realizzando progetti nei settori idrologico, agricolo, sanitario, lanciando progetti educativi.
Lunedì 15 novembre
Sono arrivata nella Provincia di Herat. L’Afghanistan è una terra remota e primitiva ma con il sapore della storia millenaria. Valli verdi interrompono distese di pietre, di polvere, di sabbia – e di rabbia! – circondate da montagne. Poche le strade asfaltate. Il cielo limpido e trasparente raccoglie il volo degli aquiloni. Il caldo della mattina precipita nel gelo della notte. Siamo sulla rotta di Marco Polo: di qui sono passati anche Gengis Khan e Tamerlano. A Herat bisognerebbe visitare l’immensa Moschea Blu, ma proibita alle donne, che pregano in casa. Intorno, minareti di fango e paglia. Quelli che restano, perché gli altri sono stati spianati dai Talebani. Oggi è la vigilia del Sacrificio di Abramo, la città si prepara ai festeggiamenti. Mercati e botteghe resteranno aperti fino a tardi, sulle strade c’è un movimento incessante.
Martedì 16 novembre
Il fondamentalismo talebano ha provato a cancellare le donne e le bambine. Ha impedito loro di studiare e di lavorare, le ha tolte dalle scuole, le ha segregate, nascoste sotto un burqa, come fantasmi celesti e muti. Per fortuna oggi c’è chi si occupa di loro. Il Female engagement teams investe sull’istruzione e le attività commerciali femminili; il Woman Social Center, una palazzina azzurra dì quattro piani appena costruita grazie al contributo dello Stato italiano, ospiterà 38 negozi e laboratori artigianali, corsi di avviamento al lavoro, internet point e biblioteca. Tutto esclusivamente per le donne del luogo. Nel pomeriggio incontro Daud Saba, il governatore della Provincia di Herat. Sono l’unica donna presente. Saba, studi internazionali e molte esperienze all’estero, ha le idee chiare e rappresenta la nuova generazione politica che guiderà il Paese durante e dopo la Transizione. Ma l’incontro più bello è quello con Maria Bashir, procuratrice capo di Herat, prima e unica donna in Afghanistan a ricoprire questo incarico in un Paese. A 40 anni, ha un già un paio di attentati alle spalle. È grazie a lei e a donne come lei se finalmente sono state approvate leggi che proteggono le afghane: oggi chiunque eserciti violenza contro le donne, anche domestica, è perseguibile per legge. E il limite di età minima, per contrarre matrimonio, in un Paese dove i parenti vendono ancora come spose bambine di 9 anni, è stato fissato a 16 anni.
La visita al carcere
Di nuovo in strada. Mi aspetta il generate dell’esercito afghano Ai Haj Ardol Abdulmajid Sadeghi, che è anche il direttore delle carceri della Regione occidentale. Entriamo nel carcere femminile di Herat – l’altro è il Badam Bagh di Kabul e sono gli unici del Paese – che attualmente ospita 120 donne e 90 bambini tra 0 e 7 anni. I bambini ci accolgono intonando un coro. Sembrano allegri, ma hanno gli occhi tristi. Mi salutano con la mano sul cuore, poi corrono a baciare l’anello che il generale porta al dito. Costruita coni fondi comunitari e un consistente contributo italiano, la prigione risponde, a una concezione rieducativa moderna sul modello della casa-famiglia. Spazi comuni, cucina gestita dalle detenute, biblioteca, salotto, scuola per mamme e bambini e aula informatica; laboratori, di sartoria e tessitura tappeti, e persino corsi di estetica e un campo di pallavolo. Mi informo sui reati più ricorrenti: contrabbando, qualche omicidio, ma soprattutto adulterio e fuga da casa. È sera, il buio di Herat fa risplendere la luce della luna e il cielo incombe, carico di stelle.
Mercoledì 17 novembre
Oggi è il mio compleanno. I militari del XIV Prt che mi ospitano mi festeggiano a colazione. Dopo la visita al maestoso mausoleo del poeta Jami – luogo di pellegrinaggio fin dall’antichità – mi riceve il capo villaggio. Devo considerarlo un grande onore, perché sono una donna (altre non ne vedo, neanche vicino ai bambini che giocano nel nulla). Qui i capi villaggio sono persone importanti, rappresentano il vertice della gerarchia sociale e del potere decisionale delle assemblee locali riconosciute, le shure. Proseguo fuori Herat, verso il Mofleh pediatric hospital, l’unico ospedale pediatrico dell’intera Provincia, costruito dalla cooperazione italiana e gestita dall’ong Aispo.
Il Mofleh è sempre affollatissimo, i 120 posti letto non bastano mai. Arrivano piccoli affetti da patologie respiratorie, da infezioni, ma soprattutto malnutriti. L’Afghanistan è il secondo Paese al mondo per mortalità infantile, e qui il tasso di fertilità è di 6,8 figli per donna. Tanti.
Il fuoco della disperazione
L’assistenza ai pazienti è una questione da donne. Ogni bambino ricoverato è circondato da almeno quattro figure femminili, mamme, zie, sorelle, cugine. Gli uomini qui non possono entrare se non nell’area del pronto soccorso o, se sono vedovi, nella zona predisposta solo per loro. Manca la sala chirurgica e c’è bisogno di personale: medici e infermieri preferiscono lavorare nelle cliniche private, dove si guadagna di più. Così, i medici volontari internazionali sono costretti a lavorare anche 15 ore di seguito.
Stessa storia all’Ospedale regionaie di Herat. Qui, nel reparto ustionati, i francesi di Humaniterra Internacional gestiscono il Centro ustionati per donne e bambini, costruito con i fondi della Comunità europea. È qui che vengono ricoverate le donne che sì danno fuoco per disperazione o in segno di protesta. E quelle «incendiate» dai parenti, che camuffano il tentato omicidio con un suicidio. Arrivano da tutte le province della zona occidentale del Paese: non ci sono altri centri specializzati e attrezzati per gli ustionati, tranne questo e quello di Kabul. Le donne che si sono date fuoco sono per lo più giovanissime, hanno tra i 12 e i 20 anni. L’anno scorso ci sono stati più di 90 casi, il che significa un aumento dei 30 per cento rispetto all’anno precedente. Queste ragazze si danno fuoco per sfuggire ai matrimoni combinati o alle violenze subite in famiglia. Si danno fuoco per protestare, perché vengono sfruttate come serve o perché i figli sono stati affidati ai mariti. Quando vengono ricoverate al Centro ustionati viene aperta un’inchiesta giudiziaria per accertare le cause, ma spesso i parenti le portano via interrompendo i trattamenti. E loro firmano le dimissioni, rassegnate, con un’impronta digitale. Nessuno le ha fatte studiare, nessuno ha insegnato loro a leggere o a scrivere.
La storia di Fatima
Sono scioccata. Ho parlato con Fatima, 17 anni, due figli piccoli, che si è incendiata non per morire ma con lo scopo di attirare l’attenzione. Il marito, tossicodipendente, la massacra di botte. Fatima è sfigurata, ma è salva, come il 55 per cento delle donne che vengono curate qui.
Ora dovrà tornare al villaggio e affrontare le conseguenze di ciò che ha fatto: l’umiliazione del ripudio e la condanna sociale. Sarà reietta, senza matrimonio, senza famiglia, senza figli. Senza vita. Dentro un burqua.
OGGI – Afghanistan – Isabella Rauti ‘Il mio viaggio nella speranza’
[File pdf - 2,1 Mb]




 FIRMA LA PETIZIONE
FIRMA LA PETIZIONE





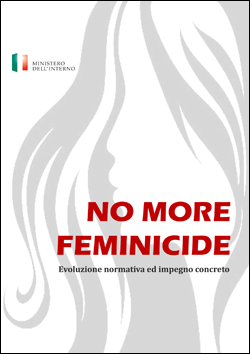

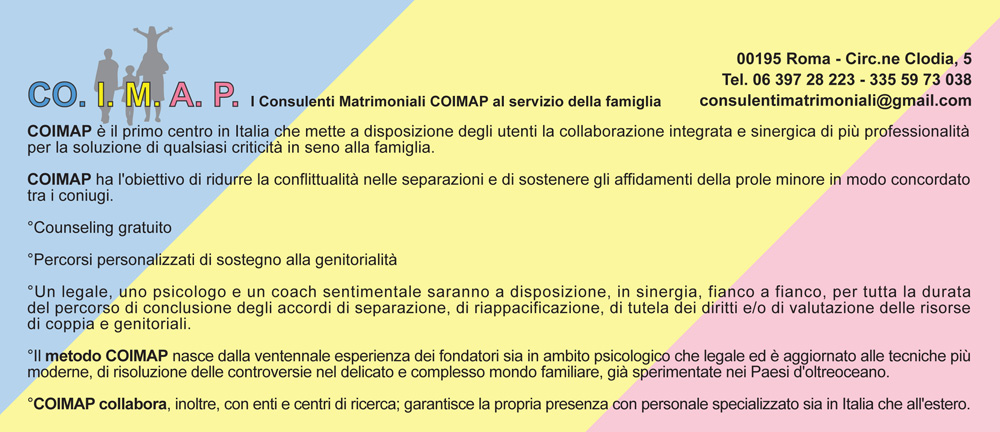
Stay Connected