di Sarah Jaffe
Se vi capitasse di leggere quella comunemente definita stampa femminista notereste un’attenzione al “soffitto di vetro” tale da far scomparire tutto il resto. Le autrici femministe celebrano i risultati della amministratore delegato di Facebook Sheryl Sandburg, acclamano la nomina di Christine Lagarde alla testa del Fondo Monetario Internazionale, restano deluse quando la amministratore delegato di Yahoo Marissa Mayer si rifiuta di essere definita una di loro o si chiedono, come ha fatto Anne Marie Slaughter sulle pagine di Atlantic, se le donne (bianche, benestanti, che hanno studiato) possano davvero “raggiungere qualsiasi obbiettivo”.
Mentre tra noi dibattiamo dei travagli di alcune tra le donne più privilegiate al mondo, la maggior parte di quelle che restano se la passano male. Secondo il “Sargent Shriver National Center on Poverty Law” le donne (negli Stati Uniti) sono quasi la metà della forza lavoro totale ma il 60 per cento dei salariati a paga minima oraria e il 73 per cento di chi lavora per le mance (i camerieri e il personale dei locali negli Usa hanno una paga ridotta al minimo e guadagnano sopratutto grazie alle mance lasciate dai clienti, ndt). Nell’area di New York, il 95 per cento dei lavoratori domestici sono donne. Il commercio, la ristorazione e il lavoro di cura a domicilio sono i settori in più rapida crescita nell’economia contemporanea e sono tutti ad alta intesità di manodopera femminile. Anche in questi settori le donne guadagnano meno. Nella ristorazione, per ogni dollaro guadagnato da un uomo, una donna mette in tasca 83 centesimi.
Sono questi gli ambienti dove la maggior parte delle donne passa il suo tempo e non ai piani alti del Googleplex (quartier generale di Google, ndt). Ed è in posti così che le femministe dovrebbero andare a dare un’occhiata. La posta in gioco è chiara. Lavoratori domestici, persone addette al lavoro di cura, infermiere e altri segmenti del mercato dove vengono impiegate soprattutto le donne devono organizzarsi. L’alternativa è un lavoro femminile sottopagato, quasi senza regole e precario. La desindacalizzazione che ha lasciato circa l’88 per cento degli americani senza sindacato trascinerà verso il basso tutte noi.
Eppure per la parte mainstream del discorso femminista è come se nell’economia nulla fosse cambiato o come se non ci fosse nulla che vale la pena analizzare dal punto di vista di genere. Mentre le rivolte in difesa dei diritti sindacali in Ohio e Wisconsin scuotevano il Paese e un movimento per la giustizia economica scendeva nelle strade e occupava parchi in giro per il mondo, mi è parso di vedere le intellettuali femministe fare un’alzata di spalle collettiva. Come ha scritto Laurie Penny sul New Statesman, “Mentre ci preoccupiamo del soffitto di vetro, ci sono ancora milioni di donne nel sottoscala – e il sottoscala è allagato”.
L’economia dalle “meravigliose sorti” rinata dopo il tracollo finanziario è costruita sui bassi salari nei servizi mentre accelera il declino del manufatturiero e le costruzioni sono a terra. All’inizio della Grande recessione l’economista Heather Boushey notava su Slate come la maggior parte del lavoro che andava perso fosse nel manifatturiero e nell’edilizia, assieme a finanza e altri ambiti degli affari. In molti parlarono di “Maschio-cessione” o di “Lui-cessione” e persino, come nel libro di Hanna Rosin, della “Fine degli uomini”. Altri hanno fatto notare che con il perdurare della crisi sono le donne ad aver subito le peggiori conseguenze a causa dei licenziamenti da quegli ambiti del settore pubblico dove queste sono occupate in prevalenza e della concorrenza dei maschi espulsi da altri settori produttivi. Secondo l’Institute for Women’s Policy Research il 60 per cento dei posti persi nel settore pubblico era occupato da donne, mentre per quanto riguarda i posti di lavoro recuperati dopo la recessione, le donne sono tornate al lavoro nel 12 per cento dei casi contro il 60 degli uomini.
Le donne sono forse sovrarappresentate nei settori in crescita dell’economia, ma è proprio in quelli che si pagano salari sotto la soglia di povertà. I tagli nel settore pubblico hanno colpito le donne in maniera sproporzionata (specie quelle di colore) e contribuiscono a determinare un tasso di disoccupazione femminile attorno all’8 per cento. I lavori sindacalizzati del pubblico spariscono e vengono sostituiti da qualche turno a Wal-Mart – e anche qui e nel resto del commercio le donne guadagnano il 90 per cento degli uomini.
“Tutti i lavori sono in qualche forma di genere e l’economia nella quale viviamo assegna un valore diverso alle mansioni sulla base di ciò” dice Ai-Jen Poo, direttore della National Domestic Workers Alliance. Poo è arrivata a organizzare il lavoro partendo dal femminismo. Da volontaria impegnata contro la violenza domestica in un rifugio per vittime immigrate asiatiche, spiega, ha capito che erano le donne con opportunità economiche a poter interrompere il ciclo della violenza. Poo accompagna una acuta analisi di genere alla battaglia per il rispetto e per un miglior trattamento di quei lavoratori, soprattutto donne, “che consentono a tutti gli altri di poter lavorare. La società ha svalutato quei lavori” dice parlando delle pulizie, del lavoro di cura, della cucina e di quegli altri lavori domestici che sono quasi sempre invisibili, “noi crediamo che una delle ragioni di questa sottovalutazione abbia molto a che vedere con chi fa quei lavori”.
Questa lettura era alla base della battaglia per l’occupazione fuori dai settori dei “colletti rosa”. Essere imprigionate in un lavoro da donna significava essere intrappolate in un determinata visione della femminilità. Rompere con i “lavori da donna” era un modo per rompere con quella mistica della femminilità denunciata da Betty Friedan. Ma quel lavoro va comunque fatto e Poo fa notare come le condizioni che hanno a lungo definito il lavoro domestico e nei servizi – instabilità, mancanza di formazione e di opportunità di carriera, bassi salari – caratterizzano in maniera crescente tutto il mercato del lavoro americano. Non solo quello delle donne. Così, quando ci concentriamo sulle pari opportunità nelle alte sfere, perdiamo di vista la questione vera, quella indicata dalla storica Bethany Moreton: “Il tema non è ‘Wow, le donne possono fare l’avvocato’, ma piuttosto che anche agli uomini capiti di fare i commessi precari”.
I datori di lavoro non solo hanno contato sul fatto di poter pagare meno le donne, ma anche su alcune qualità e competenze specifiche che si aspettavano di trovare nel lavoro femminile. Moreton, nel suo libro To Serve God and Wal-Mart raccontava come il colosso del commercio sfruttasse le qualità delle donne del Sud, bianche e cristiane che lavoravano fuori da casa per la prima volta, così come la loro disponibilità a lavorare per pochi soldi non essendo mai state pagate prima. La vocazione al servizio alla quale quelle donne sono state educate ha reso normali i bassi salari e la discriminazione di genere di cui erano vittime difficile da percepire – almeno fino a quando alcune di esse hanno deciso di fare causa.
La condizione delle donne ai gradini bassi della scala sociale ha avuto un impatto su tutti, visto che gli scalini intermedi schricchiolano o sono scomparsi del tutto. L’uso della scusa della predisposizione alla cura per pagare meno le donne ha trascinato i salari verso il basso e oggi che l’economia si basa sempre più sul lavoro in quei servizi, il fenomeno riguarda un numero sempre crescente di lavoratori. Quando i settori a più rapida crescita occupazionale sono i lavori che prevedono bassi salari non c’è vittoria per le donne, sebbene, fa notare Poo, siamo di fronte all’opportunità di ridefinire il valore del lavoro di cura, renderlo meno precario e per creare protezioni reali per i lavoratori che lo fanno. In altre parole, di smetterla di aderire in maniera insincera all’idea della “fine degli uomini” e cominciare a dare il giusto valore al lavoro delle donne.
La destra, naturalmente, argomenta che sono le donne a scegliere liberamente i lavori meno pagati perché preferiscono professioni di cura e avere più tempo per stare con i propri figli. “Non c’è motivo di ritenere che le donne avranno mai un’attitudine simile a quella degli uomini in riguardo alla genitorialtà, o che vorranno mai diventare camioniste e bibliotecarie nello stesso numero dei maschi” ha scritto il columnist di Bloomberg Ramesh Ponnuru spiegando perché noialtre in fondo non vogliamo che la disparità di paga venga superata. Ma quando un lavoro è percepito socialmente come una delle poche professioni accettabili per le donne (sia da queste che dagli uomini), dov’è la sorpresa se le donne lo “scelgono”? E quando i lavoratori che fanno quei lavori si uniscono per chiedere diritti, quelle battaglie vengono percepite come fuori dai confini della sfera di influenza del femminismo.
Gli insegnanti di Chicago, ad esempio, che hanno scioperato lo scorso settembre. Il loro sindacato, la Chicago Teachers Union è all’87% femminile ed è guidato da Karen Lewis, una riformista che è stata l’unica afroamericana nella sua classe a Dartmouth. Autorevoli maschi liberal si sono affrettati a schierarsi con il sindaco della città Rahm Emmanuel appoggiando la sua battaglia. Per farlo hanno usato una retorica antisindacale sui lavoratori pubblici strapagati diversa da quella del repubblicano governatore del Wisconsin Scott Walker solo nei toni, ma non nella sostanza.
Sul New York Tomes Nicholas Kristof ha usato gli studenti per definire le richieste degli insegnanti – che non ha elencato correttamente – come “irragionevoli” e ha chiesto che a questi venissero dati meno diritti. Dana Goldstein, autrice che si occupa di femminismo e di istruzione, ha scritto sul suo blog uno dei pochi articoli a favore del sindacato, segnalando la storia femminista dei sindacati degli insegnanti e spiegando come la scelta di assumere donne come maestre nel momento in cui il Paese si dotava di scuole pubbliche avvenne perché queste erano meno care – e perché i politici e gli intellettuali furono abili a nascondere il motivo reale dipingendo le donne come naturalmente portate, angeli moralmente superiori.
Mentre gli insegnanti scioperavano, la loro professione a prevalenza femminile veniva quindi demonizzata. Entrambi i grandi partiti erano a favore dei tagli ai salari, un sistema di valutazione attraverso test standard e minore sicurezza lavorativa. In questo caso non c’è stata nessuna protesta pubblica, come ad esempio è capitato quando la Susan G. Komen for the Cure™ha deciso di cancellare i propri finanziamenti alla pianificazione familiare. Tutto questo nonostante l’81 per cento degli insegnanti dei primi cicli di studio siano donne. Gloria Steinem ha dato il suo sostegno allo sciopero, spiegando di essere tra le confondatrici della Coalition of Labor Union Women, ma molti altri importanti blog femministi non hanno dedicato nessuna attenzione allo sciopero.
Il 30 settembre scorso, il governatore della California Jerry Brown ha posto il veto sulla storica proposta, la seconda dopo quella approvata a New York, che avrebbe dato ai lavoratori domestici protezioni simili a quelle di cui godono la maggior parte degli altri lavoratori. Il lavoro domestico è stato a lungo un luogo dell’analisi e dell’organizzazione femminista, eppure, anche nel 2012, da quello che i democratici, nelle loro mail di raccolta fondi, hanno ripetutamente definito l’anno della “guerra alle donne” da parte repubblicana, un governatore democratico ha posto il veto senza timore su una legge che avrebbe protetto soprattutto delle lavoratrici donne. “Che impatto umano ed economico avrebbe sui disabili, gli anziani e sulle loro famiglie la richiesta di riposo, pausa per i pasti e l’obbligo di vedersi pagati gli straordinari da parte di personale che fornisce cure per 24 ore?” si è chiesto Brown dopo aver elogiato il “nobile intento” della proposta. “Quali sarebbero i costi aggiuntivi e quali sono le possibilità delle famiglie che pagano per sostenere gli ultimi anni di vita dei loro cari?” ha aggiunto. I lavoratori domestici, sembra dire Brown, sono persone meno importanti di quelle di cui si prendono cura. Le femministe conoscono questa storia molto bene, in essa c’è molto della vicenda della battaglia sul lavoro domestico.
Negli anni 60 e 70 il movimento che chiedeva un salario per il lavoro domestico divenne un luogo in cui le donne chiedevano collettivamente il riconoscimento del loro lavoro. Selma James argomentava: “Quando organizziamo una lotta per il riconoscimento del salario in cambio del lavoro che facciamo in casa, chiediamo che quel lavoro venga considerato, come tutti gli altri nella società capitalista, un lavoro coatto, che non facciamo per amore ma perché, come tutti gli altri lavoratori, noi e i nostri figli moriremmo di fame se smettessimo di farlo”.
Le donne del movimento Wages for Housework erano esplicite nello spiegare che la loro richiesta di un salario era parte di una strategia per rifiutare il lavoro domestico come una parte naturale della vita di una donna. La National Domestic Workers Alliance non si organizza invece per porre fine al lavoro domestico ma per chiedere standard equi e paghe migliori. I suoi membri, spiegano, chiedono che il loro lavoro venga valutato come qualsiasi altro perché non è nella natura delle donne, soprattutto di colore e immigrate, quello in cui queste puliscano dove gli altri sporcano.
Laddove donne come James lottavano per il riconoscimento del lavoro domestico, la parte principale del movimento femminista si batteva per superarlo in favore della carriera. Come notava Barbara Ehrenreich in Global Women, l’eroina della “seconda ondata” Betty Friedan “era furiosa nei confronti di una società che consegnava le sue donne istruite a compiti che richiedono “un’intelligenza al di sotto della media” e che sarebbero – secondo studi che non citava – “particolarmente indicati alle ragazze dalla mente semplice”.
Uno dei principi fondamentali del movimento operaio è sempre stato quello secondo cui ciascun lavoro merita rispetto. Non ci sono lavori degradanti, ma condizioni degradanti. Come scrive Ehrenreich, non è il fatto che quello domestico sia un lavoro manuale che lo rende degradante – come invece riteneva Friedan – ma piuttosto il fatto che questo sia “parte integrante di una relazione degradante e finisse inevitabilmente con il rafforzarla come tale. Creare disordine con il quale sarà un’altra persona a fare i conti – i calzini gettati in terra, il dentifricio spiaccicato sullo specchio, i piatti sporchi lasciati dopo uno snack notturno – è un esercizio di dominio in una delle forme più tacite e intime”. (E sebbene Ehrenreich argomenti in questo articolo che le persone dovrebbero fare per conto proprio il lavoro domestico è allo stesso tempo stata una delle sostenitrici femministe più autorevoli della NDWA).
La National Organization for Women, ha scritto Ehrenreich, ha fatto pressione affinché il Fair Labor Standards Act includesse anche il lavoro domestico in una forma tale da percepire il lavoro domestico a pagamento come necessario affinché le donne potessero fare altri lavori più soddisfacenti. In qualche modo sostenevano il diritto a buttare quei calzini e lasciare quei piatti sporchi e sebbene volessero che le donne che se ne occupano godano di diritti, sembravano ritenere che, in fondo, quello non fosse un lavoro per loro.
Ehrenreich suggerisce che la ragione per la quale la battaglia per i diritti del lavoro domestico non si è conclusa è che i soggetti che avrebbero dovuto mantenerla viva sono in genere intellettuali e politici professionisti delle classi alte e parte di una elite di opinion-makers che ha ampiamente perso di vista quel lavoro, “come capita alle professioniste molto impegnate che lasciano la casa al mattino” .
É la classe che ha creato e mantiene la separazione tra le femministe di professione e le donne che guardano al sindacato piuttosto che al femminismo per aiutarle. Non troverete nessuna femminista che si auto definisca tale che non affermi a parole l’importanza del principio “a uguale lavoro, stessa paga”, quel che non vediamo è il legame tra il problema e le azioni che sarebbero necessarie per risolverlo. Il Paycheck Fairness Act, che consente ai lavoratori di discutere dei propri salari in maniera da scoprire le differenza di trattamento, è stato elogiato come parziale soluzione alle disparità di trattamento, sembra però persa l’idea che i lavoratori si debbano organizzare in sindacato per contrattare collettivamente condizioni e salario migliori.
Concentrandosi sulla sola questione della parità di salario ci concentriamo sulla paga oraria della singola donna confrontata a quella del singolo uomo, presumiamo che il lavoro tenda a svolgersi in un ambiente di colletti bianchi nel quale il salario si negozia individualmente e non collettivamente. Marilyn Sneiderman, organizzatrice di lavoratori per una vita e presidente di Avodah, gli Jewish Service Corps, fa notare come quella dell’avvocato che vuole diventare partner in uno studio sia una lotta individuale, mentre quella di una cameriera, di una donna delle pulizie, di un addetto alla sorveglianza, di una cameriera d’albergo non è una battaglia per salire nelle gerarchie. Piuttosto si tratta di ottenere dei giorni di malattia pagati, la sicurezza del lavoro o un aumento e quelle sono cose che si ottengono organizzandosi con i propri compagni di lavoro.
Da quando c’è un movimento operaio, di esso fanno parte le donne. Dalle infiammatrici di folle come Mary Harris “Mother” Jones, alle anarchiche come Lucy Parsons and Emma Goldman. Poo ricorda come il primo sciopero dei lavortori domestici nel Paese che si ricordi risalga al 1881. E che le donne dovettero battersi per avere posto in quel movomento. Daniel Katz, preside del National Labor College, nota come durante lo sciopero dell’industria delle confezioni del 1909, quando 20mila donne scesero in piazza per protestare per le condizioni delle fabbriche in cui lavoravano, queste non fossero solo in conflitto con i loro capi. “Le donne si mobilitarono contro i laboratori per i quali lavoravano, ma si trattò anche una rivolta contro gli uomini. La loro richiesta era quella di una eguale partecipazione al sindacato”.
Nello stesso periodo in cui i lavoratori del tessile, soprattutto immigrati, si battevano per i loro diritti, il movimento per il suffragio alle donne era in piena espansione. Le suffragette appartenevano soprattutto alla classe media ed erano in relazione con il più vasto movimento progressista di quegli anni che aveva l’obbiettivo di risollevare i poveri; Katz nota come questi vedessero questo compito come “una battaglia a due facce: contro i potenti e contro la cultura dei poveri”. In altre parole, questi dovevano essere salvati senza chiedere la loro opinione.
Mentre le lavoratrici delle confezioni facevano i picchetti, gli uomini del sindacato le lasciavano sole, vennero raggiunte da alcune suffraggette – comprese alcune note e ricche signore com Nancy Astor o Alva Vanderbilt Belmont, donne che, come nota Katz, venivano da famiglie ben più ricche di quelle dei padroni dei laboratori tessili, spesso immigrati anche loro. Nel corso della storia però le donne operaie sono sempre state restie all’idea di farsi spiegare come organizzarsi in sindacato da parte di donne benestanti.
Dorothy Sue Cobble, il cui libro The Other Women’s Movement guarda alle “femministe sindacaliste” il cui lavoro tra l’era del suffragio e la seconda onda è stato cruciale per i diritti delle donne sul posto di lavoro, sostiene che non si possano capire le battaglie per la parità femministe e il tipo di femminismo sociale che si organizzava nel movimento operaio senza usare la categoria della classe. Il movimento femminista contemporaneo non è poi così diverso. I volti noti sono soprattutto bianchi e ben istruiti, autrici di libri con le loro rubriche o direttrici di organizzazioni che si occupano di una sola questione.
Eppure le femministe di oggi sanno, o dovrebbero sapere. Cecile Richars, capo di Planned Parenthood cominciò come organizzatrice di Justice for Janitors, la campagna rivoluzionaria degli anni 90 che fece scoprire ai manager e al mondo la dignità e l’umanità dei lavoratori addetti alle pulizie, non solo nelle case ma anche a livello industriale. La maggior parte di questi erano donne, soprattutto di colore, spesso immigrate.
Eppure la partizione continua. Quando la National Football League interruppe le trattative con il sindacato degli arbitri l’anno scorso, sembrò trovare piacere nello sfruttare quella che viene percepita come la divisione tra “donne e Lavoro”, decidendo di usare una donna come arbitro sostituto per la prima volta della storia. Le femministe hanno esultato mentre nel sindacato si gemeva. Quelli di noi che sono entrambe le cose, stavano con la testa tra le mani, infuriati dalla mossa cinica della NFL, volenterosi di gioire per una nuova frontiera superata e coscienti che non tutte le prime volte di una donna sono nella direzione del progresso. Che si tratti del blocco del pagamento dei giorni di malattia da parte della speaker del consiglio municipale di New York Christine Quinn, della ascesa di Marissa Mayer a Yahoo o di Shannon Eastin (l’arbitro in questione, ndt) che prende il posto di un lavoratore escluso dal proprio lavoro (LOCKED OUT, c’è un termine sindacalese, non lo trovo) facendosi pagare meno, dobbiamo riconoscere che alcune prime volte sono a spese dei lavoratori. Che molto spesso sono donne.
Fino a quando le femministe si compiaceranno dell’ascesa delle donne nei consigli di amministrazione perché si tratta di un avanzamento della causa a prescindere da quanto avviene in quei consigli, la vera liberazione è lontana. Eppure siamo a un punto nel quale per le femministe “salvare” una lavoratrice del sesso è una attività consona, mentre partecipare a un picchetto assieme alle insegnanti o alle cameriere d’albergo non lo è. Quando Dominique Strauss-Kahn venne accusato di aver stuprato Nafissatou Diallo, una cameriera d’albergo, le femministe manifestarono in sua difesa, ma quel sostegno non ha determinato un legame più stretto con il sindacato dei lavoratori del settore, neppure mentre i lavoratori della Hyatt sono impegnati in un conflitto durissimo o quando Unite Here, il sindacato dei lavoratori d’albergo, ha sostenuto Diallo e protegge i lavoratori come lei dall’essere licenziati se e quando denunciano degli abusi subiti. L’episodio ha invece prodotto l’estasi per l’arrivo di Christine Lagarde al Fondo Monetario al posto di Strauss-Khan.
Lo scorso luglio un gruppo di attiviste, leader di comunità, lavoratori del commercio e dei ristoranti e giornalisti si sono radunati davanti al Municipio di New York per parlare dei giorni di malattia non pagati.
Non presente, ma al centro della vicenda c’era anche Gloria Steinem, luminare femminista che la stessa mattina aveva firmato un editoriale sul New York Times in sostegno di una legge che garantisse l’assenza per malattia e chiamando in causa la speaker Christine Quinn, una lesbica che spera di diventare il primo sindaco donna della città.
Quinn potrà contare sul sostegno delle femministe come Steinem quando si tratterà di fare campagna. Ma Steinem e Ai-Jen Poo e altre 200 donne influenti hanno anche firmato una lettera spiegando che il loro sostegno era anche vincolato a un suo via libera al voto della legge sulle assenza per malattia (lo speaker regola l’agenda dell’aula, ndt). Fino a quando le donne saranno le principali prestatrici di cure nelle loro famiglie e anche la maggioranza dei lavoratori a basso salario della città, questa è una battaglia femminista. E non può essere nascosta con gli appelli alla rottura del soffitto di vetro della nomina a sindaco di una donna.
La manifestazione e la campagna per premere su Quinn affinché prendesse la parte delle donne, non solo quelle benestanti, è un esempio troppo raro di leader femministe che si battono per obiettivi che sono del movimento operaio. Quinn ha tenuto duro. Ma la campagna è un segnale che forse il femminismo sta riconsiderando il proprio ruolo nei confronti dei picchetti. Il femminismo dell’effetto a cascata, invece, non porterà da nessuna parte.
Traduzione di Martino Mazzonis
[Fonte: www.reset.it]




 FIRMA LA PETIZIONE
FIRMA LA PETIZIONE





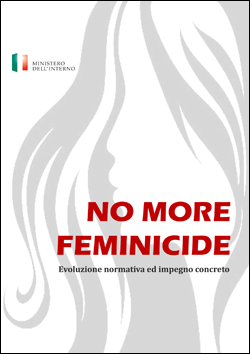

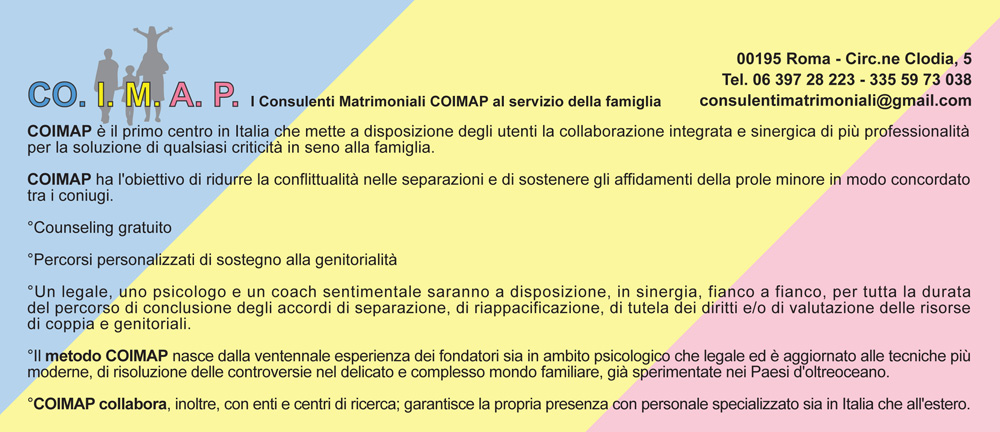
Stay Connected